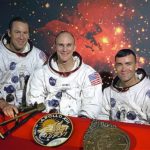- Questo articolo è stato pubblicato nel mese di maggio 2020 sul quotidiano Avvenire. Enrica Morbello Core ci ha lasciati il 10 maggio 2021.
La donna che mi guarda negli occhi mentre mi accoglie nella sua casa ha lo sguardo orgoglioso di chi sa di avere fatto nella sua vita la scelta giusta. Enrica Morbello Core ha 98 anni ma affronta il nostro incontro con un’energia sorprendente, la stessa con cui fronteggia l’emergenza causata dal coronavirus.
«Uscivo pochissimo» dice «e ora lo evito in assoluto. Ma ascolto i telegiornali, ammiro l’impegno negli ospedali di infermieri e medici che rischiano la vita. E soffro per il disastro nelle case di riposo».
Questa signora dall’espressione determinata ha avuto un’esistenza piena ed è una pittrice affermata. Ma ciò che la rende speciale, e che rende speciale il suo sguardo, è il passato da partigiana, unica donna, nome di battaglia Fasulin, ad avere, tra le montagne della Val di Susa, fatto parte della 114° Brigata Albertazzi della IV Divisione Garibaldi. Un’esperienza che ha raccontato nel libro Dalla parte giusta scritto nel 2006, a 84 anni. «L’ho fatto» spiega «con l’intento di mantenere la memoria di eventi unici, a volte terribili, e di tante emozioni che hanno mutato il corso della mia vita». E della storia.
Oggi mi accoglie nella sua casa a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Accanto a lei la figlia Fernanda, pittrice e artista come la mamma («è un dono che ho ereditato»).
«Voglio raccontare» dice subito Enrica «perché credo che mantenere vivo il ricordo di chi ha dato tanto sia un valore e anche un dovere. Pensavamo che il vivere nella paura fosse finito, invece oggi assistiamo a un ritorno di manifestazioni di fascismo, il “fascismo eterno” come lo definì Umberto Eco».
Inizia a parlare Enrica, e lo fa con passione.
«Sono nata il 28 febbraio 1922 in una famiglia antifascista in tempi in cui essere antifascisti faceva rischiare la vita. Papà Angelo, valente ebanista, aveva una falegnameria con una quarantina di operai, in gran parte assunti tra chi veniva licenziato perché non fascista, epurato perché comunista». Enrica bambina e poi ragazza si scontra con la dittatura, le leggi razziali, la persecuzione degli ebrei, la guerra. «Papà ha sempre cercato di aiutare gli ebrei. Un nostro vicino si sottrasse alla deportazione nascondendosi in un armadio a cui mio padre aveva fatto un doppio fondo».
Enrica interrompe il suo racconto. Poi: «Glielo dico perché oggi respiro di nuovo quell’odio. Quello che provo, specie nei confronti delle minacce a Liliana Segre, è indignazione, ma anche stupore. Per anni siamo vissuti nella certezza che razzismo e discriminazione fossero stati espulsi da questo Paese. Ed è stato con sorpresa che ho visto palesarsi gruppi, simboli, persone, slogan fascisti e nazisti. Ma ancora di più mi hanno colpito il tono e le parole di politici che hanno permesso che queste minoranze non avessero problemi a mostrarsi. Sono i toni, le parole, lo scagliarsi contro, la derisione, l’insulto quelli che ai miei tempi prepararono il terreno al fascismo, alle leggi razziali, alle guerre. Per questo bisogna continuare a testimoniare, per arginare l’indifferenza e l’odio con altre parole, e anche con la pratica».
E’ il maggio 1942 quando Enrica incontra Secondo Core, Dino per lei e per tutti. Dopo un mese si fidanzano, dopo poco più di un anno si sposano «perché la guerra divorava il tempo». Dino parte alla volta della Sicilia «insieme a un sergente e a 98 militari, per sostituire 100 morti in combattimento».
Il 25 luglio 1943 «la radio diffonde la notizia della caduta del fascismo e dell’arresto di Mussolini». Un mese dopo torna Dino «così provato e stravolto che non sono io ma è il nostro cane Gnif il primo a riconoscerlo». L’8 settembre, quando Badoglio annuncia l’armistizio, «pensiamo che la guerra sia finita ma la realtà è diversa». Ha 21 anni Enrica quando, al quinto mese di gravidanza, perde il suo primo bambino.
Dino decide di partire per la Val di Susa per unirsi ai partigiani. Nelle lettere che scrive, racconta a Enrica i disagi, le privazioni, i rischi. All’inizio di gennaio del 1945, in una città sotto i bombardamenti, nasce il loro secondo bambino ma non sopravvive: «Dino affronta un viaggio pericolosissimo per venire a consolarmi». Enrica decide di partire con lui alla volta di Condove: «Sento di dover dare in qualche modo il mio contributo alla lotta contro nazismo e fascismo». Lo fa con una carta di identità falsa e un nome nuovo, Enrica Simeoni, «ma per i miei compagni sarò Fasulin, Fagiolino», e con un lavoro alla Moncenisio, dove la manda il Comitato di Liberazione nazionale. «In fabbrica transitano tanti tedeschi. Si producono rotaie e vagoni per treni ma anche – di nascosto – armi per i partigiani. Paura? No. Mentre rischio la vita con mio marito, non mi rendo conto del pericolo. Ho l’incoscienza della gioventù, anche nei momenti peggiori. Riesco a occuparmi della redazione del giornalino Gioventù Valsusina, che si rivolge ai giovani della valle incitandoli alla Resistenza. Custodisco le armi nascoste in una botola. Controllo i movimenti dei tedeschi. Sono in ansia, certo. Ma contenta. Perché so di fare la cosa giusta».
Sono tempi difficili, intensi, tragici. Che oggi Enrica ripercorre mettendo in fila tanti ricordi. I due compagni partigiani trucidati da spie fasciste, «uno di loro di solo 16 anni». Dino con il fucile mitragliatore, la pistola e le bombe a mano: «La prima volta che lo vedo così mi metto a piangere». L’impegno per le donne: «Scrivo articoli dove propongo di dare loro il voto». E ancora, l’arrampicarsi sulla mulattiera che sale al comando «dove porto la poca frutta che trovo a partigiani che hanno fame».
Poi, quando il pericolo di essere denunciata si fa troppo grande, «lascio la fabbrica e prendo la strada per i monti. Entro a far parte della Brigata Albertazzi, unica donna con una ventina di uomini. Il comandante parla chiaro: come un qualsiasi altro partigiano avrei dovuto rispettare gli ordini, avere un fucile, partecipare ai turni di ronda».
La vita quotidiana non è semplice: «A pranzo e a cena mangiamo un pezzo di pane di farina di riso intinto in una latta di melassa. Lavarsi è impossibile e io non ho neppure un cambio. La maggior parte dei miei compagni ha i pidocchi. Dopo il parto, non mi è mai tornato il ciclo. Medici non ce ne sono, Dino mi manda da un veterinario amico, ma non sa aiutarmi. Penso che in fondo è una fortuna perché sarebbe stato un problema lavare le pezze di stoffa in quell’ambiente». Quello che non riuscirà mai a imparare «è sparare. Cercano di insegnarmi, ma non ce la faccio». Fa però un giornale murale, La raffica, che esce una volta sola e oggi è all’Archivio storico della Resistenza a Torino.
La anima un sentimento forte. «Quello che mi ha spinto ad andare in Val di Susa è stato il desiderio di pace, la voglia di poter contribuire, io, a fare cadere il regime fascista, a mettere fine a ingiustizia e violenza. Tante volte, anni dopo, ho raccontato la mia esperienza nelle scuole ricordando che la democrazia e la pace vanno difese, sono un bene prezioso, che diamo troppo per scontato».
Il 7 aprile 1945 i tedeschi fucilano 8 operai della fabbrica Moncenisio. «Tre giorni dopo partecipo alla mia prima battaglia. Una colonna tedesca sale verso di noi che difendiamo le posizioni tra una pioggia di proiettili. Io non so sparare, e allora passo i proiettili a un compagno che usa una mitragliatrice». Il 20 aprile altro assalto tedesco, «io devo portare in salvo i documenti e i soldi della brigata. Mi nascondo in un forno per il pane. Mentre torno inciampo nei corpi di miei compagni: in 16 erano stati trucidati».
Il 27 aprile Enrica raggiunge Torino «dove vengo presa da squadre di azione partigiana che mi scambiano per una fascista. Rischio di essere giustiziata. Solo all’ultimo riesco a dimostrare, con un foglio che ho nascosto in una piega del vestito su cui ho scritto una parola d’ordine, che sono una partigiana».
«Perché nessuno dimentichi» dopo la liberazione Enrica scrive un Diario Storico: «Compilo l’elenco dei caduti, raccolgo testimonianze». Parte di quei documenti sono ora alla Fondazione Feltrinelli di Milano. Poi con Dino torna a casa, a Casale: «La guerra è finita ma per mi ossessiona sotto forma di un incubo: vedo i tedeschi che mi inseguono, fuggo… poi mi sveglio».
Poco per volta la vita torna alla normalità, Dino ottiene un posto in Comune, a Enrica nasce una bimba prematura: anche lei non ce la fa. Entrambi collaborano alla costituzione della sezione Anpi, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia, della cittadina piemontese. «E poi il 24 gennaio 1949, un lunedì, nasce Fernanda. Dino ci ha lasciate nel 1982 ma lei ancora oggi è qui con me».
«Avere una mamma, e anche un papà così, ha significato per me crescere immersa in una scuola di riflessione politica e sociale» dice Fernanda. «Ricordo un Natale senza il mio papà che, a dire di mamma, era in montagna. In realtà era in carcere perché aveva guidato una manifestazione di protesta. È stato naturale per me continuare con la presa di coscienza, l’amore per la pace, l’impegno contro le discriminazioni».
A 98 anni Enrica continua a essere una donna straordinaria: «Trovo» dice «che oggi la parola più coraggiosa sia amore, pronunciata e ripetuta da Liliana Segre alla riunione dei Sindaci a Milano. E mi piace che nelle piazze si sia tornati a cantare Bella Ciao. Apprezzo il movimento delle sardine che si batte contro l’indifferenza e canta Bella Ciao come simbolico collegamento con la nostra storia passata. Chi non vuole odio né violenza testimonia così cosa sia la Resistenza oggi. Quella canzone mi rende felice, soprattutto perché rappresenta il passaggio del testimone».
Poco più di un anno fa Enrica Morbello ha preso parte all’opera teatrale “Pane, Pace e Libertà, storia di donne della Resistenza”. A Condove le hanno dedicato il primo Albero dei Giusti e delle Giuste.
Ma la sua Resistenza non è mai terminata. «Lo ripeto: assistiamo a un ritorno di manifestazioni di fascismo. C’è quello dei ragazzotti che usano questa definizione per giustificare il loro impulso a distruggere e menare le mani. C’è quello delle persone in apparenza per bene che tranquillamente ti dicono che vorrebbero che i migranti annegassero tutti e che prima ci sono gli italiani. C’è il fascismo che frequenta le commemorazioni di Mussolini a Predappio, che non conosce la storia, attribuisce al Duce riforme che erano precedenti e giustifica le leggi razziali e guerre. Ma il fascismo più pericoloso è quello diffuso, sdoganato dal linguaggio di prepotenza e arroganza, il fascismo degli insulti, del plauso al capo che comanda, che non conosce l’umanità senza critica politica. Se chiedessimo a queste persone se sono fasciste e razziste risponderebbero di no, perché il fascismo si nutre di mancanza di consapevolezza. È per questo che dobbiamo vigilare su questo mondo e anche su noi stessi. Perché la Resistenza non è finita».
Articoli che ti potrebbero interessare